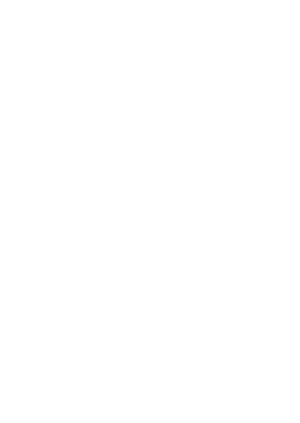cercare il senso
Voglia di lavorare saltami addosso.
La domanda nascosta:
qual è il senso di quello che facciamo?
La gente non ha più voglia di lavorare: lo scrivono anche i giornali, quindi dev’essere vero; o forse no, forse non ci siamo accorti della cosa più importante.
In nove mesi 1,6 milioni di italiani si sono auto-licenziati, in un paese dove i posti di lavoro non piovono dal cielo. Un’epidemia di pigrizia?
O forse il Covid ci ha chiesto un bilancio e ci chiediamo qual è il senso di quello che facciamo?
Senso della vita e senso del lavoro
Anche nella tua azienda la gente non ha più tanta voglia di lavorare? I capi meno giovani, semplicemente, si arrabbiano con questi “giovani che non hanno voglia di far niente”.
Tu intanto cerchi su Google parole come engagement, attraction, retention, motivazione… vorresti trovare la soluzione magica che renda sexy i task quotidiani.
Attento, in quel momento sei facile preda dei soluzionifici, che vendono le solite scorciatoie ansiolitiche ai manager in crisi.
Ma lo sai già, se una soluzione non restituisce senso a tutti (anche a te) non è una soluzione, è solo uno stratagemma di belle parole utili solo a rimandare il problema o, peggio ancora, a trovare qualcuno a cui dare la colpa.
La soglia del dolore, quella vera, è molto di più dei pain point di cui si parla nel marketing (quelli sono solo grattacapi, rogne, fastidi che allontanano i clienti). È quando fa troppo male per far finta di niente. Ecco il punto esatto: il lavoro non è più il punto centrale della vita delle persone.
In una parte della tua mente pensi: “oddio, e adesso come faccio ad arrivare ai goal aziendali previsti? ”, in un’altra però pensi “meno male, allora c’è ancora vita su questo Pianeta”, perché anche tu cominci ad averne le scatole piene.
Dentro di te sai già che il paradigma di ieri non funziona più. Intuisci anche che la soluzione reale c’è ed è lì a un metro, ma richiede l’investimento più costoso di tutti: un cambio psicologico di atteggiamento.
I lavori del c.
Graeber ne ha fatto un successo editoriale: nel suo Bullshit Jobs (edito anche in italiano da Garzanti) fa l’elenco dei lavori del c., quelli in cui “devi fingere che ci sia una ragione per cui quel lavoro esiste. Ma segretamente pensi che se questo lavoro non esistesse non farebbe alcuna differenza, o il mondo sarebbe effettivamente un posto leggermente migliore.”
Nato come un testo radicale, è diventato rapidamente mainstream: l’elenco delle categorie è spassoso: i flunkies, cioè i tirapiedi, i goons cioè quelli che sono lì perché i concorrenti hanno quella figura professionale, i duct-tapers incaricati di risolvere problemi che non esistono, i box-tickers che servono all’azienda per far finta di fare qualcosa che non fa, e ancora i task-makers che supervisionano processi che non necessitano di supervisione, eccetera.
Non tutte si possono trovare nelle medie imprese italiane, ma diverse sì.
La notizia è che qualcuno ha detto che l’imperatore è nudo (facendoci anche ridere un po’) anche se fino a ieri molti di noi avrebbero giurato che era perfettamente vestito.
La faccenda ci riguarda da vicino, noi e voi, perché tra i lavori del c. vediamo in diversi casi annoverati i vostri (manager, dirigenti, executive…) e i nostri (consulenti, formatori, coach…).
Ecco subito un’affermazione definitiva su noi e voi: più del ruolo, della retribuzione o del potere, la cosa fondamentale è il senso di quello che facciamo; il resto ne è conseguenza.
Sembra ovvio, vero? e allora perché affermarlo sembra una rivoluzione?
Il concetto di lavoro doloroso ci resta in testa per masochismo
I nodi sono venuti al pettine. Veniamo da un’idea di produzione dove il lavoro è fatica e sofferenza, una punizione che Dio ci ha inflitto alcune migliaia di anni fa ai tempi del Prometeo o della Bibbia: caro mortale, vuoi creare il mondo come un dio? Bene, se vuoi la mia forza prendila, ma sappi che soffrirai terribilmente.
Ma basta, non è vero! Abbiamo tutti sperimentato che se un lavoro ti piace, ti diverte; ci sono intere categorie che il lunedì mattina si alzano pimpanti; e non è perché fatichino di meno, è perché il loro lavoro ha senso.
Ci chiamiamo homo faber mica per scherzo, la neuro-archeologia sta dimostrando che nell’evoluzione abbiamo sviluppato la specializzazione della mano destra e quella del linguaggio contemporaneamente: senza, saremmo ancora sull’albero.
Negli ultimi 300.000 anni, il lavoro ci ha sfidato e intrigato per i primi 295.000. Poi, forse, qualcuno ha preso schiavo qualcun altro, che non si è divertito più.
Oggi sembra naturale ossessionarsi su come impieghiamo il nostro tempo e su quanto riusciamo a capitalizzarlo, ottimizzarlo, controllarlo. Ma non è affatto naturale, anzi.
Oggi abbiamo potenti schiavi in forma di macchine, computer, robot e A.I., la qualità della vita è tutta nel senso del lavoro, cioè nell’esatto contrario di quel tipo di lavoro-sofferenza senza senso.
La domanda senza senso
Così molti vengono da noi e ci chiedono: come facciamo a far tornare il lavoro al centro della vita dei nostri dipendenti?
È una domanda sbagliata e se non la si formula diversamente non troveranno mai risposte adeguate.
Questo è il passaggio più difficile: dentro di voi lo sapete già, ma qualcuno vuole che glielo diciamo noi, così ci può smentire.
Funziona spesso così, con le ovvietà psicologiche che non vogliamo accettare:
“Maestà, serve più coraggio per lottare contro una nostra belante abitudine che contro un ruggente leone a mani nude.”
(Shakespeare)
Il senso della domanda
Le persone cercano di darsi un senso nelle organizzazioni, che a loro volta cercano di avere un senso nel contesto economico, sociale, territoriale e ambientale.
Karl E. Weik lo chiama Sensemaking, significa che ciascuno cerca una visione coerente e positiva della propria relazione con gli altri. Abbiamo un senso, comprendiamo il senso delle cose che abbiamo passato insieme e degli spazi che stiamo abitando.
È un processo sociale e condiviso e continuativo di esperienze messe in comune, si riferisce a un quadro completo delle situazioni, senza disperdersi troppo nei particolari.
Parliamone
Per cambiare atteggiamento mentale non bastano i libri e i corsi: occorre il dialogo con un soggetto esterno a noi. Occorre uno sguardo dal di fuori del nostro labirinto.
Questo è il nostro mestiere di coach, non c’è un rapporto di superiorità o inferiorità, né tecnica né intellettuale, ci sono solo due punti di osservazione diversi.
Regalatevi tre ore di “consulenza zero” e vediamo insieme se una collaborazione può avere senso.
“Person looking sun distant mountains” è contrassegnato con CC0 1.0.